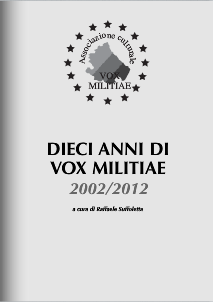«Dove tutti pensano allo stesso modo, nessuno pensa molto.»
— Walter Lippmann
di Carlo Di Stanislao
Il 1° luglio 2025, Hong Kong ha commemorato due date simboliche e contraddittorie: da un lato il 28º anniversario della sua restituzione alla Cina, celebrato con cerimonie ufficiali e dichiarazioni trionfali. Dall’altro, l’anniversario più amaro: i cinque anni dall’imposizione della Legge sulla sicurezza nazionale, che ha segnato l’inizio della repressione più sistematica nella storia recente della città.
Quella legge, presentata come un’azione “necessaria per la stabilità”, ha invece cancellato in breve tempo ogni spazio di libertà. Dove prima c’erano manifestazioni di piazza, giornalismo indipendente, partiti democratici e una vita culturale vivace, oggi c’è silenzio. Un silenzio ottenuto con la forza, con la paura, con la sorveglianza capillare. Ma Hong Kong, per quanto visibile e mediatizzata, è solo un tassello in una strategia più ampia: quella della Cina di Xi Jinping di eliminare ogni forma di dissenso, ovunque si trovi, e di rimodellare il paese secondo un’unica verità, quella del Partito.
La repressione in Cina continentale
La logica repressiva che ha soffocato Hong Kong non è una novità in Cina: è parte integrante del sistema politico del Partito Comunista. Negli ultimi dieci anni, con Xi Jinping al potere, si è intensificata fino a diventare una macchina pervasiva, alimentata dalla tecnologia e da una rigida ideologia nazionalista.
La censura è onnipresente: motori di ricerca, social network, giornali, film, videogiochi, libri scolastici. Nulla sfugge al controllo. Anche le conversazioni private, nelle università o sui gruppi di messaggistica, possono diventare oggetto di indagini. Chi critica, anche in modo moderato, rischia l’arresto, il licenziamento, l’isolamento sociale. Non esistono oppositori tollerati: esistono solo “minacce alla stabilità”.
Xinjiang: il laboratorio della repressione
La regione dello Xinjiang, dove vive la minoranza musulmana degli uiguri, rappresenta il volto più crudele della repressione cinese. Qui lo stato ha costruito una rete di “centri di rieducazione”, veri e propri campi di internamento, dove oltre un milione di persone sono state detenute senza processo. Le accuse? Avere una barba lunga, parlare in lingua uigura, pregare, viaggiare all’estero, o anche solo avere parenti religiosi.
All’interno di questi campi si verificano torture, indottrinamento forzato, sterilizzazioni, lavoro coatto. Tutto sotto il pretesto di “combattere l’estremismo”. La sorveglianza è totale: droni, telecamere, controlli biometrici, software di riconoscimento facciale. Le città uigure sono diventate prigioni a cielo aperto.
Tibet: la repressione invisibile
Meno visibile, ma non meno brutale, è la repressione in Tibet. Dopo la sanguinosa occupazione militare cinese del 1950, il Tibet è stato gradualmente trasformato in un territorio sotto stretta sorveglianza. Le rivolte del 1959 e del 2008 sono state schiacciate con la forza, e da allora il controllo è diventato capillare. I monasteri sono monitorati, le attività religiose limitate, i simboli culturali tibetani soppressi.
Il Dalai Lama è definito “un pericoloso separatista”, e solo pronunciare il suo nome può essere considerato reato. I tibetani che parlano della propria identità culturale sono accusati di “incitamento al separatismo”. Le scuole tibetane sono state chiuse o trasformate per imporre il mandarino come unica lingua d’insegnamento, cancellando generazioni di lingua e cultura locali.
Molti giovani tibetani, come già accaduto tra gli uiguri e i giovani attivisti di Hong Kong, vivono in una condizione di rassegnazione o ribellione silenziosa. Alcuni scelgono di emigrare, altri si rifugiano nel silenzio o nella religione. Alcuni, negli anni, si sono immolati con il fuoco come estremo gesto di protesta, nella più totale indifferenza delle autorità cinesi.
Taiwan nel mirino: l’ultima frontiera
Dove Hong Kong è stata “normalizzata”, dove Tibet e Xinjiang sono stati messi sotto controllo, resta Taiwan. L’isola è da tempo al centro delle mire di Pechino, che la considera una “provincia ribelle” da riportare sotto l’autorità centrale. Xi Jinping ha più volte dichiarato che la “riunificazione” con Taiwan è un obiettivo storico da realizzare «con ogni mezzo necessario».
A differenza di Hong Kong, Taiwan è uno stato de facto indipendente, con un governo democraticamente eletto, una stampa libera e una società pluralista. Ma è costantemente sotto pressione: minacce militari, campagne di disinformazione, manovre economiche e diplomatiche. I cieli attorno all’isola sono regolarmente attraversati da aerei militari cinesi, le sue acque pattugliate da navi da guerra.
Per Pechino, Taiwan rappresenta l’ultimo ostacolo alla costruzione di una Cina “totale”, senza eccezioni e senza voci fuori dal coro. Per i taiwanesi, rappresenta invece la linea del confine: oltre quella, non c’è solo la perdita dell’indipendenza politica, ma anche della libertà personale, della cultura, della memoria.
Un Paese, una voce sola
Tutte queste realtà — Hong Kong, Xinjiang, Tibet, Taiwan — mostrano un’unica traiettoria: la volontà del Partito Comunista Cinese di controllare ogni aspetto della vita pubblica e privata. In nome della “stabilità”, Pechino ha costruito un sistema che cancella le differenze culturali, linguistiche, religiose e politiche. Le minoranze vengono assimilate o represse. Le città autonome vengono normalizzate. Gli intellettuali critici vengono messi a tacere. I giovani vengono indottrinati.
Quello che viene chiamato “ritorno alla normalità” è in realtà un ritorno al conformismo forzato. Una società in cui tutti fingono di essere d’accordo per sopravvivere. Dove la libertà non viene solo negata, ma dimenticata.
Il prezzo del silenzio
Eppure qualcosa resiste. Nei ricordi delle proteste del 2019, nei libri messi al bando, nelle canzoni censurate, negli occhi di chi ha pagato con il carcere o l’esilio. Resiste nella solidarietà silenziosa, nei gesti anonimi di dissenso, nelle parole scritte in codice sui social, nelle scuole clandestine, nella cultura che trova sempre una via per sopravvivere.
Cinque anni dopo l’inizio della repressione a Hong Kong, e decenni dopo l’occupazione del Tibet e la campagna contro gli uiguri, la Cina è un paese che brilla per potenza economica, ma che vive sotto un enorme peso: quello di milioni di voci soffocate.
E su Taiwan, l’ombra si allunga.