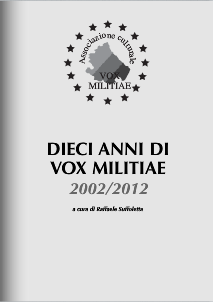Enrico Cavalli
PREMESSA. La conoscenza territoriale è presupposto della sua valorizzazione culturale ed in senso di indotto socioeconomico, specie, per le più giovani generazioni, in una ricostruzione identitaria del Comitatus Aquilanus (sorto dal 1254).
CONTESTO DI RIFERIMENTO. Nella Valle del fiume Aterno, avente al centro il Colle di Sant’Onofrio, ad Est il massiccio appenninico del Gran Sasso D’Italia e ad Ovest l’Altopiano delle Rocche, centomila anni fa, c’era un gigantesco lago del “Pleistocene”, finché, non viene risucchiato dalle orogenesi.
In quest’area omogenea, geograficamente e antropologicamente, i fiumi hanno rappresentato nel tempo un luogo di aggregazione e comunicazione demografica.
Insediamenti paleolitici, coi mutati climi, lasciano il posto a quelli neolitici, finché, come in tutto il Centro Meridione della penisola, si è assistito a flussi dei Pelasgi (popoli pre Ellenici), noti per le costruzioni megalitiche.
In era Italica, la Valle Dell’Aterno, vedeva a Nord, Sabini (prossimi ai Marsi, Piceni, Osci, Umbri: probabilmente, il “nomen” prendono da “Sabo”, divinità delle “Tavole Eugubine” del XV secolo a.C.), a Sud, i Vestini (prossimi ai Peligni, Marrucini), entrambi i gruppi del ceppo Sabellico, ebbero come caratteristiche prevalenti, gli uni, comunitarie e pastorali, gli altri, individualistiche ed agricole.
Il confine geografico tra le due aree, sistemandolo con coordinate odierne, era per latitudine, tra il Monte Luco a Rojo e il Monte San Franco D’Assergi, per longitudine, il Colle a Bazzano.
AMITERNUM. Ai margini Ovest della Sabina interna, derivava il toponimo, per l’essere ai lati del fiume Aterno, ossia, Ante-Aternum (intorno all’Aterno).
In zona insistono nuclei degli Aborigeni (dal latino “ab origine-dall’origine”, cioè, gli abitanti originari di un luogo) e Greci aventi per capitale Lista (vicino Rieti) ed il centro di Paterna sul lago di Cutiliae, definito “umbilicus Italiae-ombelico D’Italia” dallo scrittore latino Varrone.
Le migrazioni osco-sabelliche per il “ver sacrum-sorgente sacra” e dai santuaridel Piceno, interessano l’area, e, narra Catone circa una Testruna-Testrina (odierna Sella Di Corno), come nevralgica per questi spostamenti demici.
Qui, spiccano gli abitanti di Amiternum che scacciano gli Aborigeni,memorabile, l’assedio notturno di queste roccaforti, nel giudizio di Dionigi D’Alicarnasso in “Antiquitates Romanae” (Liber I et II, 7 a.C.), e, legittimano la supremazia emergente dei Sabini, estesa da Nursia (Norcia, in Umbria) ad Offidium (Bazzano, frazione di Paganica fino al 1927, quando, entrambi, entrano nel “Grande Comune” dell’Aquila…).
E’capitale sabina, Amiternun, dagli agglomerati nuovi di Foruli (l’odierna frazione di Scoppito, Civitatomassa, ma, dal nome del barone Tommaso Di Preturo a fine secolo XII), e, Pitinum (Pettino, borgo dell’Aquila), tutti punti strategici della transumanza, e, se, il poeta Virgilio, cita la ”ingens Amiterna cohors priscique Quirites-ingente coorte di Amiterno e degli antichi Quiriti” in ausilio a Turno re dei Rutuli contro il troiano Enea, è possibile che il leggendario rapimento delle Sabine, voluto dal primo re di Roma, Romolo, nell’VIII secolo a.C., poté avvenire in uno dei “circenses” amiternini.
Tito Tazio, il re sabino, reagisce all’affronto romano, e, c’è la battaglia del Lago Curzio del 751 a.C., conclusa dalla pace del “Quirinale” (la narrazione, vuol, indotta dalla donne sabine rapite); ma, dal regno di Tarquinio Prisco sino al III secolo a.C., pur in una fusione etnica, ci saranno, almeno, otto conflitti fra Roma e Sabina e dalle alterne vicende non oltre il IV secolo a.C..
Lungo i tragitti della secolare transumanza di greggi e dei luoghi di mercato, sorgevano dedicazioni ad Ercole, inoltre in caso di calamità, guerre, sovrademismi, si consacravano a Marte i nati nella primavera successiva.
Presenza di decorazioni dionisiache, cioè, misteriche, in letti, triclini, corredi vari per ritualità legate al ciclo della vita, denotano credenze di aspettativa ultraterrena; al termine delle divinazioni sacerdotali, si inscenavano nelle arene manifestazioni di baldanza fisica in combattimenti a corpo libero e/o armati, dopo opportuno addestramento dei contendenti in palestre e rinvigorimento in vasche termali.
Tra il IV e V secolo a.C., c’è diversa articolazione degli abitati tra pianura e collina in funzione dei poli religiosi; sorgono statue anche colossali e templi in onore di varie divinità della natura: Feronia, venerata per via etrusca, protettrice dei luoghi incolti, acque, schiavi liberati; Silvano, custode dei boschi; Vacuna, dea dei campi; Vesta, dea del focolare domestico; Tiche-Fortuna, dea della prosperità civica (in età romana, invocata per il divo-imperatore Augusto reduce dalle battaglie orientali); Cibele, a guida di un carro e detta la “Grande Madre”.
Nel 293 a.C., stando allo storico Tito Livio, il generale console Spurio Carvilio Massimo nelle manovre anti popoli che premevano in morsa su Roma, cioè, gli Etruschi e Sanniti, insidia Amiternum, conquistata nel 290 a.C., dal generale console Manlio Dentato che riunisce in tribù “Quirite” gli amiternini e che legati alla impostazione italica di “vici et pagi-vichi e villaggi” tendenti a fare un “comitatus-comitato”, ottengono la cittadinanza romana senza voto; sottolinea il corfiniese Sila Italico in “Punica” del 101 d.C., che l’Amiternino diede a Publio Cornelio Scipione dei volontari a Canne nel 216 a.C., sebbene, l’area sarà attraversata dal condottiero cartaginese Annibale nel 211 a.C. che devasta il tempio di “Feronia”.
Amiternum dai diecimila abitanti, riedificata più a valle dell’insediamento sabino eretta a “praefectura-prefettura”, non conosce la “Guerra Sociale” del 91-89 a.C., né la “Guerra Civile Repubblicana” del I secolo a.C., anzi, costruendosi, l’acquedotto dell’Aquae Arentane; tuttavia, dallo scrittore Strabone, apprendiamo di contrasti territoriali, visibile nella Foruli ridotto di ribelli antitriumvirali nel 36 a.C..
Dopo la vittoria di Ottaviano ad Azio nel 31 a.C., c’è una pacificazione d’area, sotto forma di riassetti fondiari indotta dalla appartenenza di molte famiglie locali al partito augusteo ed alla influenza di patriziati capitolini, si pensi ai Mucii Scevolae proprietari in Foruli ed alle matrone dell’aristocrazia senatoria, Labetia Crispina e Crispina Augusta la consorte dell’imperatore Commodo, stessi legami di maggiorenti amiternini con Roma: si pensi a Caio Crispo Sallustio, impresario (realizzò giardini fra attuale Via Veneto e Palazzo Quirinale in Roma) scrittore della forma latina più eccelsa (assieme a Cicerone), politico (vicino all’amico Giulio Cesare) ad Appio Claudio Ceco capo dei magistrati (i “decemviri-dieci uomini”) e console.
Di queste reciproche trame centro-periferia, ne sono indici le dediche amiternine a Lucio Cesare, al futuro Imperatore Tiberio definito patrono di Foruli ed ai suoi due “divi-eccelsi” genitori Livia Drusilla, Augusto, in cui onore saranno i “ludi-giochi” del 2 d.C., a cura del dinamico ceto forulense dei Silvano.
Ne deriva, la costituzione del “municipium-municipio” amiternino; a questo centro di potere e dei servizi, sovraintendevano da magistrati del tempio e colonie (gli “octoviri-otto uomini”) e due magistrati edili; giusta la dedica alla dea Fortuna, tali magistrature assistite dai “quinquennales-quinquennali”, “magistri iuvenum-giovani maestri”, “quaestores-questori” per la cura amministrativa, contabile, infine, dall’”ordo decurionum-ordine dei consiglieri”, il “senatus-senato” locale dal parere pregnante per il governo di un territorio conservativo di “praefectura” per un invalso prestigio e dotato del “praetorium-pretorio” (dove si inurbò Preturo, frazione dell’Aquila dal 29 luglio 1927) e di “foro-sito di affari principali” coi “fasti-gloria” delle magistrature.
Amiternum, esibiva un calendario di eventi, anniversari imperiali ed annonarie, forse, per carestie nel 60 d.C., un teatro all’”Ara di Saturno”, l’anfiteatro di seimila posti per i “ludi” al lato della arteria ed il quarto nella penisola di età dei Flavi come in fulgore per i Severi, patrocinatori di terme; insigni, le “domus-case signorili”, sontuosi templi e mausolei ad opera anche degli attivi liberti, per Ercole, Minerva; a Foruli, l’allaccio nel 47 d.C. alla Via Claudia Nova in congiunzione alla Claudia Valeria, ovvero, la conferma di snodo strategico sugli antichissimi percorsi della transumanza toccante le plaghe dei Vestini, in direzione dell’Apulia (Puglia).
Emergono, i ludi, segno di adesione alla ideologia imperiale, da parte dei maggiorenti autoctoni avevano sistematiche cadenze e luoghi celebrativi: quelli tenuti in una piazza, si chiamavano “compitalicii-filantropici”, oppure, “scaenici-per giocatori” se in un teatro stabile, tuttavia, esistendo una caratterizzazione privata dello svago per la plebe, in questo caso, denominabile “lusus-gioco” ed allestito da un “editor ludi-organizzatore ludico”.
Nei seimila sedili in gradinata, dell’anfiteatro di Amiternum, un ignoto personaggio figlio di un autorità di rango equestre, forse, i Salii collegabili all’era dei Severi, durante il “munus-ruolo” di Cornelianus, fregiandosi dell’indulgenza imperiale, elargiva alla folla quattro coppie di gladiatori, intorno al 260 d.C.; si ha notizia di “edizioni-edizioni”offerti da Lucio Vibius Secerus patrono della “civitas-città” di Superaequanorum, per l’ascesa edile del proprio figlio, nel 271 d.C.; il “probo-saggio” C. Sallius Sofronius Pompeianus diede diversi spettacoli circensi e del “certamen gymnicus-prova ginnasiarca” in linea all’era nuova Costantino Il Grande ed iscritti nella “tabula-tavola” dal magistrato apposito, per questi eventi, Caius Sallius Proculus, nel 325 d.C..
Ad Amiternum tardo romana, i “pauperes-poveri” andranno ad abitare le costruzioni di età dei Flavi, ma, senza più gli accenti della pugna gladiatoria, in adeguamento al Cristianesimo.
Si attesta l’”ordo splendissimus-ordine splendido” dell’”ager Amiterninus-agro di Amiterno”, grazie sempre ai Salii: Proculus, assomma la carica di “sacerdos-sacerdote” Lanivinus e diventa patrono delle città di Vestina Cismontana di Aveja (Fossa), Peltuinum (Prata D’Ansidonia); attivo è il probo Sofronius, per restauri della curia decurionale, acquedotto, terme, porticati abbelliti da nuove statue, il tutto, inaugurato da rappresentazioni teatrali alla presenza del “corrector-ispettore” della provincia Claudio Uranio ed in coincidenza dell’ascesa a Cesare (vice Augusto Imperatore)di Costanzo Cloro, nel 325 d.C..
L’altra faccia di quelle copiose iniziative edilizie, potrebbe essere stata una crisi urbana, parzialmente, risolta all’indomani della dedicazione di una statua a L.Turcius Secundus, nuovo “corrector” della provincia Flaminia et Picenum, in quanto l’area fu oggetto di un sisma nel 346 d.C., che toccò il centro della penisola e le cui negative conseguenze socioeconomiche, pare lecito ipotizzare.
Citata anche da Tito Livio, Plinio Il Vecchio ad ulteriore certificazione della sua importanza, Amiternum, amministrativamente, fu in provincia Valeria, la XII su XVII, della ex Regione IV Agustea et Adrianea, poi, della Flaminia et Picenum di età Dioclezianea, e, avanti il 400 d.C., da questa ultima, distaccatasi per denominarsi in omologa consolare; la Valeria nel 458 d.C., incluse la Sabina, Vestina, Marsica (capitale Marruvium-San Benedetto Dei Marsi) Reate (Rieti, sede di un Praesis–Governatore), Tiburim (Tivoli), Carseolis (Carsoli), Nursia (Norcia).
VESTINA (Cismontana).
Comuni attestazioni di antichi studiosi della civiltà Italica, parlano di gente Sannita, staccatasi dal ramo principale durante una “primavera sacra” e che prese il nome di Vestini.
A condurre queste popolazioni, fuori dalle loro sedi originarie dalla Apulia alla Campania-Felix, infatti, fu l’insegna di Vesta, dea della fecondità venerabile in Grecia ed in penisola Italica più che in area indogermanica, sebbene, a questa cultualità “nazionale” si affiancasse quella per Silvano, preferita a Giove-Ercole, Mercurio, Venere.
I Vestini, nonostante i Piceni, si insediarono dalla Frentania fino al Mons Fiscellus-Gran Sasso (poi, D’Italia), secondo la rappresentazione di “Tavola Peutingeriana” del IV secolo a.C.,per poi degradare da questa sommità nella bassa Valle Dell’Aterno, da cui la divisione, richiamabile da Plinio Il Vecchio, fra Trasmontana con capitale Pinna-Penne e Cismontana avente per “direzionalità” Peltuinum-Prata D’Ansidonia e dove il ruolo femminile lo ritroviamo nel 242 d.C., se si conferisce ad una consacrata a Venere l’onore di patrona della prefettura, un segno di spiccata religiosità d’area poste lapidi votive ad Ercole e Mercurio.
Il centro Vestino per eccellenza nei luoghi del versante meridionale aquilano del Mons Fiscellus Gran Sasso, rispetto a Furfo-Barisciano, Caput‘Trium’Amnium- Capestrano, Frustenine-Rocca Di Mezzo, Aveja-Fossa, Pagus Fificulanus-Paganica, era Aufinum-Ofena, sede di un anfiteatro.
I Vestini, abitavano in “vicatim-quartieri” indipendenti in linea alle agglomerazioni individualiste dei popoli vicini di ceppo Osco-Sabellico con cui ebbero tarde contaminazioni; in sostanza, le genti stavano in autonomi villaggi dipendenti da formali autorità rurali, a loro volta, entro reggimenti repubblicani detti “toutas-del popolo”, come dall’iscrizione del Guerriero Di Capestrano rinvenuto nel 1932, e, difesi da muraglie di muraglie in numero di trentasette, secondo le recenti acquisizioni archeologiche, in schema a “tholoi-costruzioni” in pietra a secco e dalla falsa cupola tipiche delle generali etnie mediterranee; tali baluardi, destinati ad incidere nella vicenda storica autoctona, come quelli a ridosso del Monte Cagno di Ocre e Monte Cerro di Casentino ora in Fossa; la fortificazione più massiccia era quella di Separa, probabilmente, vicina al centro di Sinizzo, poi, scomparsa nel mistero a vantaggio di Peltuinum.
Dall’VIII secolo a.C., la fisionomia megalitica dell’area di nostro interesse è chiusa dal Monte di Manicola, dall’etimo latino di “moenia-muraglia”.
Nel 1992, a Fossa, la scoperta della più estesa necropoli del Centro Italia databile dal IX-VIII (l’età del ferro) al I secolo a.C., definita la “Stonhenge D’Abruzzo” per la sua organizzazione geometrica essendo i “menhir-tumuli” maschili a formare un cerchio; per inciso, rinvenute propaggini sepolcrali Italiche anche a Bazzano, Caporciano, Capestrano.
A togliere dall’autoisolamento i Vestini, furono gli effetti delle tre guerre dei Sanniti coi Romani dal 343-290 a.C..
I consoli Furio Camillo e Bruto Sceva nel 326 a.C., stando a Tito Livio, pretesero dal “Senato” di potere attaccare via la Sabina, preventivamente, i Vestini che cercheranno vanamente di tenere le fortezze di Cutina e Cingilia (nell’odierno Pescarese); per essersi sfilacciati nel 305 a.C., dalla coalizione messa su dai Marsi, le città della Vestina non si vedevano annullati antichi privilegi, tipo il conio della moneta loro evocativa “Ves”, da Roma, che però chiese a tutta la stirpe dei sabellici il pagamento di tasse e contingenti di soldati nelle campagne in Medio Oriente e II Guerra anti Cartagine.
La zona romanizzata, dunque, entra nel Pagus Frentanus-Pago Frentano (la capitale era Anxanum-Lanciano), quest’ultima assegnazione amministrativa, avente un’attinenza comune al culto misterico di Bacco data la specializzazione vignicola dei medesimi Vestini.
La “Federazione” fra Italici e Romani, essendo squilibrata a favore dei secondi, portò alla formazione della “Lega Italica” a Corfinio (per inciso, presso Sulmo-Sulmona, patria del poeta Ovidio) nel 90 a.C., cui presero parte i Vestini, il punto solido dello schieramento Sud-Est contrario a Roma, come dal rinvenimento di numerosi reperti di “missili” di piombo a losanga sul Monte di Manicola, ma che guidati dal “dittatore” della Marsica, Quinto Poppedio Silone, vennero battuti dall’esercito del console Gneo Pompeo Strabone, il vincitore, definitivamente, sui popoli “ribelli” quanto divisi, ad Ascoli.
Va detto che Aveja, successiva capitale della Cismontana, rimase neutrale rispetto a Roma, come dalla introduzione in area dei culti capitolini e presenza di lapidi votive al “Sol Invictus-Sole Invitto”; nella “Lex Julia De Civitate-Legge Julia della Città”, concessiva della “romana civica-cittadinanza romana” a tutti gli Italici non insorti, si inserirono, progressivamente, gli stessi Vestini, laddove, significativamente, si rafforzano cultualità per Bacco, Giove Ercolino fervente nel Paganichese, mentre di rilievo, a Furconium-Forcona, nei pressi della futura Civita Di Bagno, canalizzazioni e vasche idriche su vari livelli convergenti su di un edificio sacro, c’era una sorta di tempio delle acque il “Balneum-Bagno” per una religiosità che calamitava i ceti elitari romani, incessantemente, legata ai cicli dell’agricoltura; spostandoci al confine della Vestina Transmontana, in Valle Del Tirino, un tempietto di Venere vide una leggendaria sacerdotessa-custode, Calvisia, che aggettivò in seguito i centri di Carapelle e Castelvecchio (Calvisio).
Nel 27 a.C., la Vestina sarà della IV’ Regio Augustea, poi, Dioclezianea, della Provincia Valeria, per una circoscrizione avente il “municipium” e prefettura di Aveja con giurisdizione sulle “civitas” di Furconium e Peltuinum (Prata D’Ansidonia).
Quanto all’ascendenza avejana, essa, fece da snodo della transumanza che unisce la Valle dell’Aterno, essendo patrono dei Vestini, il patrizio amiternino Proculus, ma, questa polarità decade al IV secolo d.C., sia per lo spostamento verso la costa adriatica degli interessi imperiali, che per sismi e straripamenti-impaludamenti dell’Aterno.