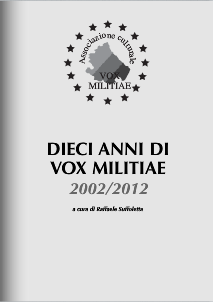Giuseppe Lalli
Poteva accadere nei primi secoli dell’era cristiana, all’inizio di quell’affascinante stagione della storia che è il Medioevo, che in questi luoghi remoti e solitari dell’Appennino alcuni giovani, magari provenienti da famiglie gentilizie come San Benedetto da Norcia, giovani assetati di assoluto, sentissero il bisogno di unirsi per poter condurre vita comune nella pratica della nuova religione del Dio incarnato; e fondavano un monastero. Più tardi, attorno al monastero cominciavano a stabilire le loro dimore i montanari dei dintorni, e si iniziava a disboscare e dissodare le terre circostanti. E la chiesa diventava punto di aggregazione comunitaria, liturgica e civica, tempio e municipio di quell’uomo medievale che era unitario, non schizofrenico come l’uomo moderno.
Per una di quelle singolari circostanze che si osservano nella storia, e che i credenti dovrebbero chiamare non ‘coincidenze’ ma “Dio-incidenze”, in uno stesso periodo è è nato un castello, una chiesa (che non a caso ad Assergi sorge su uno sperone roccioso, in una posizione di difesa strategica e che coincide con uno dei bastioni delle mura di cinta del castello stesso, quasi a volerne costituire la difesa spirituale e materiale) e un uomo, il futuro San Franco, un monaco benedettino che verrà in queste montagne spinto da una vocazione cristiana più radicale, destinato ad incrociare il suo destino con castello e una chiesa da poco nati.
La quasi millenaria vita della chiesa-santuario di Assergi è strettamente legata alla memoria di San Franco.
Le notizie su questa originale figura di anacoreta ci vengono quasi tutte dagli Atti, una biografia del santo consistente in un antico manoscritto in latino medievale che fu conservato nella chiesa parrocchiale di Assergi fino al 1791 e poi andato perduto. Nicola Tomei (1718–1792), che lo ebbe tra le mani, nella citata Dissertazione lo descrive come un piccolo codice membranaceo scritto in carattere antico abbastanza intellegibile, con lettere iniziali miniate, contenente la vita, morte e miracoli di S. Franco.
Il Tomei assegna il manoscritto agli ultimi decenni del secolo XIII (a differenza di qualche altro studioso, che lo colloca in età posteriore, comunque non al di là dei primi decenni del secolo successivo) e crede che si tratti della stesura primitiva o di una copia ricavata da essa. Pensa altresì che lo scritto debba attribuirsi ad un monaco o a un prete di Assergi, contemporaneo del santo, che aveva inteso tramandare avvenimenti a cui aveva assistito o che aveva udito raccontare da chi ne era stato testimone. Si deve quindi ritenere che ci troviamo di fronte a un testo scritto quando il santo era morto da poco. Oltre a quella riportata dal Tomei nella sua Dissertazione, di versioni degli Atti ne esistono altre tre: una, riportata dai Bollandisti, redatta dal gesuita Antonio Beatillo (1570-1642), a cui il Tomei muove puntuali critiche di ordine filologico, e altre due, curate dallo studioso benedettino Costantino Caetani(1568-1650), custodite nella Biblioteca Universitaria Alessandrina di Roma. Pur presentando queste quattro versioni alcune varianti grammaticali e sintattiche, oltre che nell’estensione della narrazione riferita ai miracoli attribuiti al santo post mortem, esse sostanzialmente concordano nel testo, e si possono persino disporre in lettura sinottica, come del resto ha fatto Demetrio Gianfrancesco (1922 – 2004), parroco di Assergi dal 1954 al 1976, nel suo fondamentale libro (D. GIANFRANCESCO Assergi e S. Franco – Eremita del Gran Sasso, Roma, abete grafica s.p.a. 1980)
Che cosa ci dicono questi Atti ?
Franco nasce all’inizio della seconda metà del XII secolo, allorché la dominazione normanna nell’Italia meridionale volge al declino. L’anonimo biografo non riporta la data di nascita, ma ci fornisce, in relazione ad essa, dei riferimenti storici, tra i quali il più stringente è quello relativo al papato di Adriano IV (4 dicembre 1154 – 1° settembre 1159, in tutto 4 anni e circa nove mesi, periodo in cui possiamo collocare la nascita di Franco).
Nessun dubbio invece sul luogo: nasce a Roio (pagus Ruidus, riferito all’epoca romana, o, più tardi, in età medievale, Castellum Roge, o anche Castrum Rodii, come si legge in alcuni antichi documenti (nota: Varie sono le ipotesi circa l’origine del nome ‘Roio’ e della sua provenienza fonetica. Sul tema cfr. R. CROCE, Roio: Storia di una terra attraverso i secoli, L’Aquila, Rea Edizioni, 2020, pp. 21-27. Negli Atti di San Franco, in riferimento al luogo di nascita, si legge «in Castello, quod Rodium dicitur»), che al tempo, pur appartenendo al contado amiternino, faceva parte della diocesi di Forcona, antica città romana sopra nominata che sorgeva nei pressi dell’attuale Civita di Bagno. (Nota: In un edificio dell’attuale frazione di Roio Piano una lapide apposta sul muro ricorda che quella era la casa natale di San Franco. Per la verità, la casa, a giudicare dalle mura esterne, mostra di risalire al XIX secolo, non certo al XII, il secolo in cui Franco nacque. È probabile che l’attuale costruzione sorga sul sito dove la tradizione collocava la casa originaria della famiglia del santo).
Franco nasce da un’agiata famiglia di allevatori, e mostra ben presto di essere un ragazzo intelligente e virtuoso. Il padre lo affida alle cure del prete Palmerio, forse il parroco del paese, affinché gli dia i primi rudimenti. Nell’animo del ragazzo matura assai presto la vocazione religiosa, e un giorno in cui un suo fratello maggiore, forse mosso da invidia, lo costringeva a pascolare le pecore, fugge e bussa alla porta del monastero benedettinodi San Giovanni in Collimento, a Lucoli.(nota: Cfr. M. D’ANTONIO, Abbazie benedettine in Abruzzo, Carsa Edizioni, Sambuceto di San Giovanni Teatino (Ch), 2003, pp. 136-137). Qui, resistendo alle insistenze dei genitori che volevano che tornasse a casa, completa gli studi e conduce per vent’anni una esemplare vita di monaco, rifiutando, alla morte dell’abate, di sostituirlo alla guida della comunità, nonostante la volontà espressa dai monaci.
Spinto da un desiderio di perfezione maggiore, una notte, scambiato un commosso abbraccio con i suoi compagni, prende congedo da loro e si rifugia dapprima in una grotta vicino ai boschi di Lucoli e poi, sfuggendo ai tanti devoti che, spinti dalla fama che presto si diffonde delle sue virtù e dei suoi prodigi, desiderano incontrarlo, vaga
dalle parti di Montereale, per poi raggiungere un luogo remoto sopra il territorio del Vasto, dove miracolosamente fa sgorgare una sorgente d’acqua pura e dove rimane per cinque anni. Ma nemmeno questo, a lungo andare, gli pare posto adatto alla sua esigenza di solitudine. Molta gente va a fargli visita, e allora si sposta verso i monti sopra Assergi, sistemandosi in una spelonca sotto una rupe. La tradizione ha identificato in una grotta sotto le rocce di Pizzo Cefalone e in un’altra più in basso, detta ‘I Peschioli’, i due eremi dove l’eremita trascorse i suoi ultimi quindici anni, conducendo vita austera e compiendo molti miracoli. (nota: Cfr. D. GIANFRANCESCO, Assergi e S. Franco, cit., p. 334; cfr. E. MICATI, L’eremitismo, in L’abruzzo nel Medioevo, cit., pp. 296-298; ID, Eremi d’Abruzzo – Guida ai luoghi di culto rupestri, Pescara, CARSA EDIZIONI, 2004, pp. 91-92). Scendeva a valle solo nei giorni festivi per assistere alla messa nella chiesa di Assergi, al tempo gestita da monaci.
Quando Franco rende l’anima a Dio (la notte tra il 4 e il 5 giugno, stando ad una consolidata tradizione, di un imprecisato anno tra il 1220 e il 1230, secondo un ragionevole e prudente calcolo ricavato dalla cronologia che si evince dagli Atti ( nota: Il primo a parlare di 1220 è Nicola Tomei nel suo più volte citato libro su (….) mentre è Morelli a indicare, per la morte del santo il periodo 1220-1230 il lasso di tempo (M. Morelli, S. Franco di Assergi nella vita eremitica dell’Abruzzo aquilano, 1958 vol. dattilosritto, riportato in D. GIANFRANCESCO, Assergi e s. Franco…, cit., p. 339) le campane della chiesa di Assergi suonano da sole; i monaci, insieme a tutto il popolo, svegliati e commossi, vedono una luce che promana dalla grotta dell’eremita e intuiscono ciò che è accaduto. Raggiungono l’eremo. Canti e lacrime si confondono, depongono devotamente in una barella il corpo che odora soavemente e lo trasportano a valle. Più che un corteo funebre dovette trattarsi di una piccola marcia trionfale. Possiamo immaginare che il corteo entra nel castello di Assergi e si dirige verso la chiesa. Nella cripta vengono tumulate le spoglie mortali di colui che per il popolo è già santo. Dopo qualche tempo le ossa verranno estratte e sistemate in una cassa di pietra andata perduta e della quale si conserva il solo coperchio, dove è scritto in latino: Qui riposa il corpo di Franco(ne), sacerdote di Dio, 5 giugno.
Questi dati storici mostrano come che la vicenda di questo santo, ancorché assai lontana nel tempo, sia pure con qualche incertezza temporale e inesattezza che si riscontra negli Atti in riferimento al contesto politico in cui è collocata la nascita di Franco, è storicamente attendibile. Inoltre, come di seguito si illustrerà, la sua vicenda è inquadrabile in una determinata epoca e in una più ampia geografia spirituale.
Quella di San Franco è una vicenda certamente originale, ma niente affatto isolata.
Essa si comprende meglio alla luce di un fenomeno, quello dell’eremitismo dei secoli centrali del Medioevo, che interessò l’Italia e l’Europa. Ciò avveniva in un contesto sociale caratterizzato da una forte crescita economica e da una intensificazione dei rapporti commerciali. (nota A. VAUCHEZ La spiritualità dell’Occidente medioevale, Cles (Tn), Edizioni Corriere della Sera, 2021, pp. 81-83; J. LE GOFF, La civiltà dell’Occidente medievale, Einaudi, Cles (Tn), 2023, pp. 71-75.
Già dalla fine del X secolo, e in modo particolare nei secoli XI e il XII, l’età in cui vive Franco, nel quadro di un’epoca percorsa da fermenti di rinnovamento evangelico a cui non sono estranee attese di tipo apocalittico, alla crisi del monachesimo tradizionale corrisponde una rinnovata fioritura spirituale, che si manifesta, da un lato, in forme più o meno organizzate che presto verranno inquadrate nei grandi Ordini Mendicanti (i Domenicani e i Francescani, per citare i più famosi); dall’altro, in forme libere e individuali, come è il caso del nostro eremita (note: C. VIOLANTE, in AA.VV, L’eremitismo in Occidente nei secoli XI e XII, Atti della seconda settimana internazionale di studio, Mendola, 30 agosto-6 settembre 1962, Milano, Società Editrice Vita e Pensiero, 1965, pp.
10-23; A. VAUCHEZ, La spiritualità dell’Occidente medioevale...cit., p. 86-87…; cfr. J. LECLERCQ, La crise du monachisme aux siècles XI e XII in Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 70, 1958, pp. 19-41; S. ZUCCHINI, “Vecchio e nuovo” monachesimo tra primo e secondo millennio – estratto da “Riforma o restaurazione ?” – Atti del XXVI Convegno del Centro Studi Avellaniti, Fonte Avellana, 29-30 agosto 2004, Il Segno dei Gabrielli Editori, 2006, pp. 83-100).
La vita eremitica non è certo invenzione del XII secolo. Senza parlare dei primi secoli cristiani, già nell’alto Medioevo nei monasteri benedettini l’abate, sia pure eccezionalmente, poteva autorizzare un monaco di provate qualità spirituali ad allontanarsi dalla comunità per vivere per qualche tempo nel deserto. Ma è solo a partire dall’XI secolo e soprattutto nel XII che l’eremitismo diviene un fenomeno più generale che si presenta come un’alternativa alla vita monastica tradizionale. (nota: A. VAUCHEZ, La spiritualità dell’Occidente medioevale, cit., p. 93.)
Questo eremitismo – per così dire – della seconda ondata differisce da quello dei primi secoli dell’era cristiana in più di un punto. Se quello antico si caratterizza per la ricerca del deserto (prevale la fuga dal mondo), quello medievale, che è profondamente segnato dalla prevalenza della regola monastica di San Benedetto, tende ad armonizzarsi con il contesto sociale. (nota: Cfr. J. LECLERCQ, L’érémitisme en Occident jusq’à l’an mil, in L’eremitismo in Occidente…cit., pp. 27-44; L. GÉNICOT, L’érémitisme du XI siècle dans son contexte économique et social, inL’eremitismo in Occidente…cit., pp. 45-69; cfr. A. VAUCHEZ, La spiritualità dell’Occidente medioevale, cit., pp. 94-95.
La vicenda di Franco, a saperla leggere, è intrisa di questa socialità. Dagli Atti traspare abbastanza chiaramente come in Franco la fuga dal mondo convive, sia pure in maniera problematica, con l’apertura al mondo. Vediamo che egli, da un lato non si sottrae al rapporto con quanti lo cercano, dall’altro cerca sì di isolarsi, ma è un isolamento che è dettato dall’esigenza di mantenere la pace interiore sulla punta dell’anima ed è finalizzato ad attingere da un rapporto più intenso con Dio la forza per abbracciare tutto e tutti.
Un’altra differenza tra questo eremitismo e quello antico attiene ad un aspetto all’apparenza pratico ma che ha conseguenze anche di ordine spirituale: mentre gli anacoreti dei primi secoli sono dediti alle attività manuali, con le quali si procacciano il necessario per vivere, quelli del tempo di Franco vengono assai spesso riforniti dai devoti. L’eremita, al contrario del cenobita, diventa in questa età una figura familiare, perché incontra la gente: la vita contemplativa non esclude le relazioni umane. (nota: Cfr. C. VIOLANTE, L’eremitismo in Occidente nei secoli XI e XII – Atti della seconda Settimana internazionale di studio, Mendola 30 agosto-6 settembre 1962, Milano,Società Editrice Vita ePensiero, 1965, pp. 18-19. Cfr. G. G. MEERSSEMAN, Eremitismo e predicazione itinerante dei secoli XI e XII, in L’eremitismo in Occidente nei secoli XI e XII, cit., p. 164, in Atti della seconda Settimana internazionale di studio, Mendola 30 agosto-6 settembre 1962, Milano1965 (Miscellanea del Centro di Studi medioevali, IV), pp. 164-181; E. MICATI, “Eremi e luogo di culto
S. BOESCH GAJANO, Paesaggio, solitudine, taumatologia, Pescara, Carsa, 1996, p. 9;
Un particolare colpisce della biografia del giovane Franco. Egli è di buona famiglia. I suoi appartengono ad una classe sociale che con terminologia moderna potremmo definire di piccola borghesia agraria, che vive di pastorizia e commercializzazione della lana, attività che, come si è rilevato nella pagine precedenti, conosce in questo periodo nel versante aquilano del massiccio del Gran Sasso un forte incremento a motivo della reviviscenza della transumanza. (nota: sul tema della transumanza si veda la nota…nel paragrafo riferito al contesto storico-sociale).
Il giovane Franco, intelligente e sensibile, realizza ben presto che quello di una tranquilla esistenza di agiato possidente non può essere il suo ideale di vita. Egli chiede alla vita un senso. C’è, da parte sua, una richiesta di sensoche è anche una larvata protesta nei confronti di una certa ipocrisia di una società che già mostra i segni dell’opulenza, a cui Franco oppone la scelta della radicalità cristiana, un atteggiamento analogo a quello che sarà del coevo Francesco d’Assisi (1181/82–1226), sia pure declinato in forme diverse. (mettere in nota: Il Clementi, a proposito dell’esperienza eremitica di Franco, scrive: «Siamo di fronte ad uno dei tanti esempi della crisi del cenobitismo che investe anche l’Abruzzo […]: una imitazione del Cristo nella sua poverissima nudità» (A. CLEMENTI, L’organizzazione demica…, cit., p. 38).
Franco ci appare tutt’altro che un misantropo. Se fosse stato un misantropo, o un asociale, i monaci di Lucoli non lo avrebbero preferito come loro capo; e quando ha preso commiato dai suoi confratelli li ha abbracciati con le lacrime agli occhi. È anche un uomo colto: alla scuola del prete Palmerio – leggiamo negli Atti – si distingue per capacità di apprendimento, per poi proseguire la sua preparazione intellettuale in convento.
Girovagando tra queste montagne, magari alla ricerca di frutti di bosco, avrà sicuramente esercitato l’apostolato occasionale. Quante liti tra pastori avrà sedato; quante dispute tra piccoli proprietari, magari per questioni di confini, avrà composto; quanti consigli a vecchi e a giovani avrà dispensato; e quanta paziente direzione spirituale avrà potuto esercitare anche tra i suoi stessi confratelli del convento di Assergi, che lo avranno considerato un fratello maggiore, un compagno impegnato su una sorta di prima linea dello spirito. Avrà perfino, di tanto in tanto, di ritorno dalla chiesa di Assergi, dove si recava nelle feste per assistere alla messa, accettato di mangiare un pezzo di pane e un po’ di pecorino con i pastori.
C’è, infine, da supporre che Franco sia stato un attento e curioso osservatore di un panorama sociale e ambientale che stava mutando. È questa l’epoca in cui l’assetto feudale, come dianzi accennato, cede il passo alla proprietà demaniale, mentre la transumanza, attività che, come già detto, in quest’età conosce una forte ripresa, e che richiede pascoli sempre più estesi e a quote sempre più alte, ha come conseguenza un’intensa opera di disboscamento. (nota A. CLEMENTI, S. Franco d’Assergi eremita attento al mondo, in Bullettino della Deputazione di storia patria – a. 91.(2001), pp. 5-36.
Sarebbe fuorviante giudicare la vicenda di Franco con le sole categorie umane. Gli stessi miracoli, che spesso ci parlano di un ritrovato equilibrio tra l’uomo e la natura, servono all’uomo di Dio a mostrare “i nuovi cieli e le nuove terre”, cioè l’anticipo di ciò che attende una umanità riconciliata, nella Grazia, con la natura; oltre che e a far vedere ciò che doveva essere il mondo prima che il peccato intervenisse a rompere l’equilibrio che Dio aveva stabilito. Al tempo stesso Franco mostra come la natura stessa sia un miracolo permanente per chi la voglia vedere con gli occhi della fede: il grano che cresce, l’acqua che scorre, gli alberi che danno frutti. Il suo profondo messaggio, incentrato sulla ricerca di Dio nel silenzio e nella preghiera, a contatto con la nuda poesia di una natura incontaminata, ce lo mostrano un “pellegrino dell’Assoluto”, secondo la bella immagine che di lui ha dato Giacomo Sansoni, autore di un’affascinante storia romanzata dell’uomo di Dio.
Il culto popolare del santo inizia subito dopo la morte. Il vescovo di Forcona prima e quello dell’Aquila dopo dovettero riconoscere le virtù eroiche dell’eremita, e così San Franco ebbe il suo altare, la sua ufficiatura e la sua festa liturgica, il 5 giugno.
(nota: Occorre chiarire, a questo riguardo, che all’epoca in cui visse San Franco la canonizzazione in capo al papa, pur essendo già in vigore, non si era ancora del tutto consolidata nella prassi ecclesiale, e questa “zona grigia” perdurò anche dopo che Gregorio IX (1227–1241), nel 1234, inserendo nelle sue decretali il breve Audivimus, aveva inteso estendere la nuova prassi alla chiesa universale (cfr. A. VAUCHEZ, La santità nel medioevo, San Giovanni in Persiceto (Bo), Società Editrice il Mulino, 2009, pp. 25-63; N. TOMEI, Dissertazione…cit., pp. 106-113. )
Non si deve tuttavia pensare che quella locale fosse una prassi sbrigativa nella quale il vescovo si limitasse a sancire automaticamente il fervore popolare. Al contrario, si trattava di un procedimento assai rigoroso. Anche se la “vox populi” era considerata un indizio importante, l’approvazione del vescovo non era affatto scontata. In riferimento a San Franco, giova poi rilevare che se delle due approvazioni, del vescovo di Forcona prima e di quello dell’Aquila dopo, non vi è traccia scritta, ciò è sicuramente dovuto, come puntualmente rileva lo stesso Tomei a pag. 122 della sua Dissertazione, agli effetti perniciosi sia dei terremoti che si sono succeduti nella città dell’Aquila, sia degli incendi dell’Archivio della Curia vescovile. Del resto, come il Tomei non manca di far notare nella stessa pagina, mai nella chiesa di Assergi si sarebbe potuto praticare da parte del clero il culto di San Franco, che si deduce essere antico e ufficializzato, senza l’espressa autorizzazione dell’autorità ecclesiastica competente e sulla base di un Diploma (in seguito perduto per una delle ragioni anzidette) spedito una prima volta dal vescovo di Forcona e poi confermato dai suoi successori.
La fama di santità dell’eremita del Gran Sasso si diffonde assai presto e oltrepassa gli stessi confini dell’Abruzzo.
Più tardi, la Chiesa, a motivo dei numerosi miracoli da lui compiuti in vita e dopo morte, riconoscerà e confermerà il suo culto liturgico.
(nota) Su richiesta di Nicola Tomei, preposto, come si è dianzi detto, di Assergi dal 1742 al 1764, papa Benedetto XIV (1740–1758), con Breve del 17 maggio 1749, concesse l’indulgenza plenaria a chi il 5 giugno, nella chiesa di Assergi, partecipasse alla S. Messa e al rito della processione (N. TOMEI, Dissertazione, cit., pp. 112-113.), indulgenza in seguito rinnovata.
………………………………………………………………………………………….
Attualmente il San Franco si festeggia nei paesi che furono toccati dalla sua biografia: Roio, naturalmente, il suo paese natale, Lucoli, nella cui abbazia visse per vent’anni, Arischia, il cui territorio è vicino all’Acqua di S. Franco, Ortolano, frazione di Campotosto la cui chiesa parrocchiale è intitolata al santo eremita; ed è poi protettore, oltre che di Assergi, di una piccola frazione di Isola del Gran Sasso, Forca di Valle, dove il santo è rappresentato non solo, in omaggio all’iconografia tradizionale, come un anziano monaco con la barba, ma anche, in una nicchia poco fuori dal centro abitato, come un giovane pastore, a voler ricordare forse che la beatitudine che ci attende in Cielo reca i tratti dell’eterna giovinezza.
Nell’anno 2020 si è celebrato l’Ottocentenario della morte del Santo.